Archive for the ‘Il Foglio’ Category
Subcomandante Dibba

Lui sa, ma non ha le prove. Di Battista sa che dietro il massacro mediatico di Danilo, nome in codice da guerrigliero di Toninelli, c’è la mano dei Benetton – lo ha insinuato l’altra sera, pasolineggiando, da Fazio. Del resto, è opinione comune tra giacobini, inquisitori e incroci vari tra le due razze che le prove siano sopravvalutate (“Per credere a un complotto voi avete bisogno di prove giuridiche; a me basta l’andamento della situazione generale, le relazioni dei nemici della libertà, gli andirivieni di certi agenti del potere”, aveva detto Marat). Di Battista sa. Forse suo cugino ha le prove. Io invece non so. Magari so abbastanza per sapere che lui non sa e neppure suo cugino, in un intreccio gnoseologico che più che a Pasolini fa pensare a un vecchio film con Alberto Sordi e Monica Vitti. Ma resta il fatto che non so; e tuttavia, se dovessi anch’io far finta di sapere, inclinerei a sospettare che la mano dei Benetton o di altri Savi di Sion della finanza cosmopolita c’è, occulta e potentissima, proprio dietro l’ascesa di Di Battista. Seguitemi: sono un cazzaro di talento. Leggi il seguito di questo post »
Oltreparlamentarismo

Quando ho voglia di indispettire un amico magistrato (ma non fino al punto di farmi incriminare) rispolvero un mio vecchio progetto fantagiuridico di riforma della procedura penale. Già oggi molti processi si celebrano sui media più che nelle aule di giustizia, gli dico, e tutto fa supporre che le cose andranno peggiorando. Forse non sarà domani, magari neppure dopodomani, ma verrà il giorno in cui constateremo che abbiamo perso la guerra, che è velleitario cercare di mettere la cavezza alla bestiaccia indocile dell’informazione giudiziaria o sperare di ricondurre all’ovile dei tribunali la pecorella smarrita del processo, che ha preso l’abitudine di pascolare un po’ dove gli capita. Quando quel giorno arriverà, sarà bene che ci trovi pronti con in mano un codice garantista per disciplinare il rito mediatico, che l’imputato potrà scegliere come oggi sceglie, se gli conviene, il rito abbreviato. Il processo penale si svolgerà direttamente in uno studio televisivo e nelle forme di uno show, ma in condizioni di perfetta parità tra le parti, con regole precise di acquisizione delle prove e di escussione delle testimonianze. Se vogliamo, sarebbe un’estensione dell’area di giurisdizione di format arbitrali come l’americano Judge Judy o il nostro Forum (magari meno soporifero), nonché un taglio drastico di quel nodo che Antoine Garapon, nel suo saggio sul rituale giudiziario, chiamava la “delocalizzazione della scena giudiziaria nei media”. Dico queste cose con la faccia serissima, vedo l’amico magistrato che s’irrigidisce, sbuffa, scalpita, ma dopo aver riso un poco a sue spese mi rabbuio e piombo nello sconforto anch’io. Leggi il seguito di questo post »
Il capro inutile

A furia di speculare sull’infinitamente grande e sull’infinitamente piccolo, rischiamo di perdere di vista quello che Flaiano chiamava l’infinitamente medio. Sotto i nostri occhi si dispiega ogni giorno un rutilante caleidoscopio di lapidazioni simboliche, gogne medievali o maoiste, scene di caccia in bassa Padania, rituali di degradazione, linciaggi, colonne infami, imputazioni paranoidi, scaricamenti di barile, roghi di spaventapasseri; ma ci siamo abituati a osservare questa fantasmagoria cangiante tramite un lunghissimo cannocchiale archetipico, quello del capro espiatorio, quasi una costante antropologica disinvolta dal tempo e dallo spazio. Così facendo siamo di volta in volta pettegoli o moralisti classici, cronachisti in affanno sugli eventi o filosofi che li giudicano sotto la specie dell’eternità: e invece sarebbe buona cosa ragionare da politici. Leggi il seguito di questo post »
Il conservatore umarell

Piccola parabola senza pretese. Il paziente è affetto da un male nuovo, per il quale non esiste un nome diagnostico o un protocollo terapeutico sperimentato. Si teme che sia mortale, malgrado molti obiettino che non ci sono ancora nel mondo casi conclamati di decesso. Il quadro sintomatico è in parte già noto ma lascia comunque sconcertati, perché i sintomi si presentano combinati in modo insolito. Ricorda malattie che si credevano debellate da decenni, e per questo alcuni medici ripropongono vecchi rimedi; altri applicano cure palliative, per guadagnare tempo in attesa che si scopra la terapia; altri ancora, con quell’estro improvvisatorio che solo l’angoscia fa germinare, s’inventano protocolli sperimentali, che dopo successi estemporanei si rivelano deludenti. Gli amici del malato, assiepati nel piccolo anfiteatro a gradoni che un vetro separa dal blocco operatorio, assistono con apprensione a questi sforzi; pregano che si trovi la cura, certo, ma se dei medici pietosi prolungano anche di poco la vita del loro caro, è una benedizione: poiché lo amano, farebbero di tutto per riaverlo con sé, anche infiacchito e malandato. Sui gradoni, però, si notano alcuni osservatori dal contegno indecifrabile. Dicono di voler bene anche loro al malato, ma tutto quel che fanno è irridere gli uomini in camice bianco. Quel chirurgo maneggia male il bisturi, dice uno. Si crede un luminare della medicina ma i suoi sforzi boriosi non faranno che accelerare la proliferazione del morbo, gli fa eco un altro. Anzi – parlottano tra di loro, con un mezzo sorriso sarcastico – sono proprio questi medici ad aver causato la malattia, e se adesso il paziente muore, ben gli sta. Gli amici staccano per un istante il naso dal vetro, si girano allibiti ad ascoltarli e si chiedono: vogliono davvero bene, costoro, al poveretto sotto i ferri? Leggi il seguito di questo post »
Che cosa non è la Tradizione

Ripenso a un epigramma dell’infallibile Giorgio Calcagno: “Rusconi, un dì la gente / era migliore d’oggi: / ma sul conto corrente / val più la ‘Gente’ d’‘Oggi’”. Sono passati alcuni decenni, e la matassa di quelle allusioni satiriche va sbrogliata. Sotto lo stesso marchio editoriale, notava maliziosamente Calcagno, convivevano la Tradizione e il rotocalco, l’aristocrazia dello spirito e la chiacchiera illustrata, il disprezzo del mondo moderno e i paparazzi. La pars destruens era spesso sopraffina, e grazie a consulenti come Elémire Zolla e Augusto Del Noce nel catalogo Rusconi approdarono le opere di Simone Weil e di Cristina Campo, di J.R.R. Tolkien e di Pavel Florenskij. Quanto alla pars construens, be’, quella era un altro paio di maniche. Zolla, saggiamente, se ne disinteressò sempre, e il tentativo di “imprimere scosse galvaniche a corpi mistici di già cadaverici”, come era stato il caso del fascismo, gli pareva una truffa spirituale da negromanti. Non ha avuto eredi, ed era scontato che non ne avesse, tanto erano idiosincratiche le sue vie. Del Noce di eredi ne ha avuti invece fin troppi, e il suo nome di questi tempi è tornato a circolare più del solito, specie per quella profezia sul suicidio della rivoluzione che avrebbe trasformato il Pci in un “partito radicale di massa” (verrebbe da dire: magari). Sfogliando certa stampa di destra si ha a volte l’impressione di trovarsi davanti a riedizioni punk del Sabato, il battagliero settimanale cattolico su cui scriveva anche Del Noce. Alcuni bersagli variano, altri restano identici: la bestia nera della secolarizzazione, il mondo della finanza osservato con la prurigine un po’ fobica e un po’ lubrica di chi si sente escluso da un sabba misterioso, la progenie satanica di Eugenio Scalfari – che il nuovo Papa, affronto supremo e peccato contro lo Spirito, si è scelto come interlocutore. Aspetto al varco il primo che accuserà Bergoglio di essere uno gnostico camuffato: è nell’aria. Leggi il seguito di questo post »
Il governo anatra-coniglio

Ne ha uccisi più il wishful thinking della guerra. La capacità della mente umana di accomodare i fatti ai desideri è virtualmente inesauribile, come dimostra il caso di Paul Rassinier, comunista, torturato dalla Gestapo, deportato a Buchenwald, che divenne tuttavia il battistrada dei negazionisti. Poiché le leggi della dialettica marxista non riuscivano a spiegare i campi di sterminio, i campi di sterminio non erano mai esistiti. “Pazzo d’ideologia, non amava certo i suoi carnefici, ma la propria visione del mondo”, scrisse Alain Finkielkraut in L’avenir d’une négation, contrastando l’idea comune che il suo fosse un caso di sindrome di Stoccolma. Vedete bene che non c’è freno alla potenza dell’autoinganno ideologico, e che al cospetto di questo caso limite sbiadiscono gli esempi più ordinari che abbiamo sotto gli occhi: schiere di politici, intellettuali e commentatori che per sopprimere la “dissonanza cognitiva” e farsi andar giù almeno metà del governo giallo-verde stanno facendo alla propria mente più o meno quel che il Canaro della Magliana fece alla sua vittima, in particolare lo shampoo al cervello. Sono i liberali per Salvini e i progressisti per Di Maio – due casi di scuola di bovarismo ideologico, se per bovarismo intendiamo non già, astrattamente, l’intossicarsi di trame romanzesche, quanto il bisogno che ha la disperata Emma di fingere che un dongiovanni come Rodolphe sia tutt’altro uomo da quel che appare. Leggi il seguito di questo post »
Benvenuti nella savana inquisitoria

Nella città di Acchiappacitrulli, affollata di animali parlanti, può capitare che un vecchio pappagallo ti dia una soffiata per condurre il gatto e la volpe a processo da un gorilla; ma se mi chiedessero un’allegoria dell’Italia del 2018 non sceglierei Pinocchio, sceglierei una stampa del primo Novecento dove animali di varia specie – un elefante, un ippopotamo, un orso, un rinoceronte, una volpe, perfino una dignitosissima giraffa col pince-nez – sono radunati sotto lo scranno di un giudice leone imparruccato. Del resto, la savana ha le sue gerarchie. Malgrado il nome feroce, le Iene stanno piuttosto in basso nella catena alimentare delle inquisizioni, dove molti altri animali giornalistici, politici e polizieschi – l’habitat potrebbe arricchirsi di una bestia nuova, l’agente infiltrato – si divorano a vicenda sotto l’occhio di quei giudici leoni che, diceva Francis Bacon, sarebbe bene restassero sotto il trono, e che invece ne hanno fatto il loro giaciglio; e che, proprio come i leoni, possono starsene a sonnecchiare tutto il giorno, salvo dare un ruggito o cacciar fuori una zampa per far intendere chi comanda. È una lotta fratricida di inquisizioni concorrenti all’ombra della grande inquisizione. In un punto imprecisato della catena si trova la specie ibrida della commissione antimafia – bizzarro incrocio tra un tribunale, un comitato di salute pubblica e un’agenzia di stampa – e il suo nuovo presidente, il grillino Nicola Morra, ha già mostrato gli artigli. Lui, l’intellettuale del Movimento – pressappoco come Scarpinato è l’intellettuale della Procura di Palermo – ha detto che serve un controllo di moralità per gli iscritti agli ordini professionali; e che nessuno, lui neppure, è immune dal sospetto. Leggi il seguito di questo post »
Vespa contro le Vespe
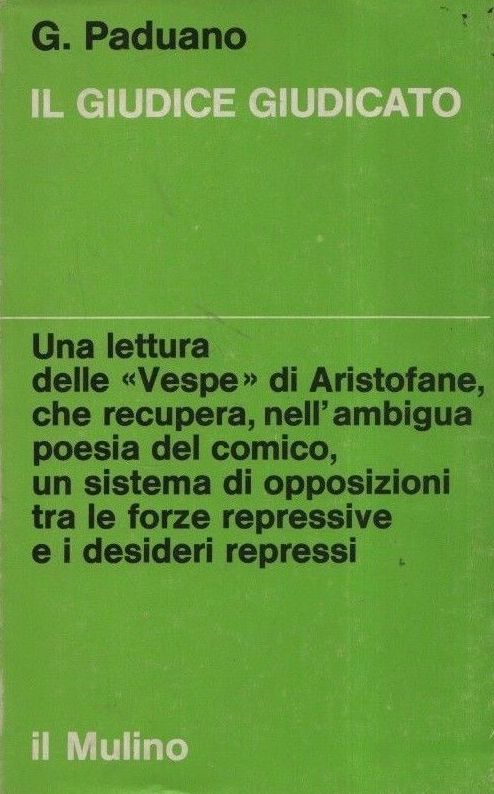
Martedì sera, intorno alle nove e mezza, uno squarcio anomalo nella rete del tempo ha fatto sì che gli italiani del 2018 d.C., seduti davanti ai loro televisori, si confondessero per qualche prodigioso istante con gli ateniesi del 422 a.C. convenuti al Teatro di Dioniso per festeggiare le Lenee. E una felice coincidenza onomastica – l’espediente di cui più spesso si serve la poetic justice per eseguire i suoi verdetti, o compiere le sue beffarde nemesi – ha voluto che fosse Bruno Vespa a rimettere in scena le Vespe, la commedia di Aristofane sull’ossessione per i processi, e sui giudici smaniosi di conficcare il proprio pungiglione nella carne di un imputato purchessia. Nella parte del vecchio Filocleone – “affetto da una malattia stranissima che non verrebbe in mente a nessuno”, la mania dei tribunali, un uomo che “col suo carattere bilioso, vota sempre per la condanna di tutti” – c’era l’imenottero Davigo. Il culmine più lampantemente aristofanesco, lì nel teatro di Floris, c’è stato quando Vespa ha detto che se sua nonna teneva sul comodino il ritratto di Giovanni XXIII e qualcun altro un libro o la foto del figlio, Davigo ci tiene le manette: “Lui si sveglia dicendo: ma oggi a chi tocca?”. Proprio come Filocleone, che la notte non chiude occhio per l’ansia di presentarsi alle udienze, e che “se il gallo canta verso sera, subito lo accusa di essersi fatto corrompere dagli imputati, per svegliarlo in ritardo”. In quel momento, credetemi, mentre tenevo gli occhi fissi sullo schermo, con una mano mi toccavo il petto, per esser certo di aver addosso la mia camicia e non un chitone da antico ateniese. Leggi il seguito di questo post »
Processo alla borghesia

Diceva Luigi Einaudi – campione delle prediche inutili, in ogni campo – che borghesia è parola così equivoca che sarebbe buona cosa “escluderla dal novero di quelle adoperate dalle persone decise a non imbrogliare il prossimo”. È naturale, perciò, che sia tornata a risuonare nell’epoca dell’imbroglio deliberato e permanente. La sconnessa “Ode alla borghesia” firmata da Beppe Grillo e dal suo neurologo rimesta tra fonti per lo più canzonettistiche: il Gaber prematuramente declinante e sermoneggiante – campione delle prediche dannose, in ogni campo –, qualche eco camuffata dei canti di lotta di Claudio Lolli (saluta, Grillo, la “cara vecchia borghesia”), a cui si aggiungono reminiscenze involontarie e tic verbali variamente sovrapposti, dagli anni Venti agli anni Settanta – i due strati più corposi e indigesti della pentalasagna. Leggi il seguito di questo post »
Meditazioni pascaliane sulla prescrizione

Il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi spaventa, scriveva Pascal, che non aveva neppure osato immaginare l’eterno ruminio dei processi infiniti, non si era spinto fino a concepire la visione dantesca di una Giudecca giudiziaria dove il magistrato-Lucifero strazia coi denti, “a guisa di maciulla”, l’imputato finito per disavventura nelle sue fauci. C’è qualcosa di sottilmente metafisico nell’emendamento Bonafede, per quanto suoni comico pronunciare nello stesso respiro quel cognome e quell’attributo. “Hanno inventato la categoria del processo eterno”, ha detto un grande studioso del diritto penale, Tullio Padovani, in una bella intervista al Dubbio di qualche giorno fa. “Una durata eterna è ragionevole?”, si è chiesto – ed è domanda squisitamente filosofica. Ma la ragionevolezza inscritta nei principi costituzionali è appena una debole canna, un nonnulla sospeso tra due infiniti, l’infinito del processo e l’infinito del crimine, che vicendevolmente si implicano. Un pascaliano moderno, il filosofo e moralista Vladimir Jankélévitch, scrisse quasi cinquant’anni fa un saggio sull’“imprescrittibile”. È possibile prescrivere i crimini della Shoah? La saggezza del diritto ordinario, rispondeva Jankélévitch, non si può applicare alla dimensione esorbitante di un “crimine metafisico”, espressione di una “malignità ontologica” che lascia muti e annichiliti come il firmamento di Pascal: “Propriamente parlando, il grandioso massacro non è un crimine su scala umana; non più delle grandezze astronomiche e degli anni-luce”. Imprescrittibile, irreparabile e quindi per sua natura inespiabile, se non altro nel tempo breve della vita umana. Leggi il seguito di questo post »
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.